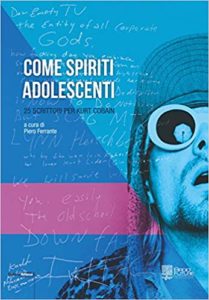Piero Ferrante e “Come Spiriti Adolescenti”
Caro iCrewer, per la nostra rubrica “Sogni di Carta” e dopo aver letto l’antologia di racconti da lui curata “Come Spiriti Adolescenti” eccomi a intervistare Piero Ferrante.
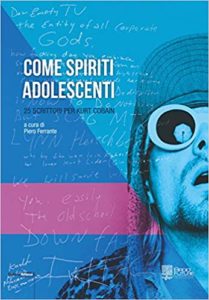
Iniziamo con una presentazione: chi è Piero Ferrante?
Piero Ferrante è uno che non ama parlare tanto di Piero Ferrante. In effetti, pensandoci, non ho mai pensato a una definizione su me stesso. Allora faccio adesso quello che faccio di solito quando non so rispondere a una domanda: cerco la risposta tra le pieghe di una canzone e dico che potrei applicare a me stesso poche parole di “Come un fiume”, un pezzo dei Nomadi, definendomi uno con “l’aria battagliera che lo invade”.
Questo perché credo che per “essere al mondo” non basta “stare nel mondo”: serve mettervisi dentro nelle sue contraddizioni. E percorrerle, attraverso l’impegno. O raccontarle, con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizioni sia una chitarra accordata male o la tastiera di un computer, una matita o una bomboletta spray.

Come hai reclutato i vari autori che hanno scritto i vari racconti di “Come spiriti adolescenti?
Ecco “reclutato” è la parola giusta. In fondo siamo una specie di piccolo plotone sconclusionato che al posto dei fucili imbraccia Stratocaster.
Al di là delle definizioni, tutto nasce da un pretesto: raccontare quel che restava in noi, a livello emozionale, del nostro rapporto con le canzoni dei Nirvana in un anno particolare, questo 2019, in cui cade il venticinquennale del suicidio di Kurt Cobain.
L’idea di mettere insieme 25 autori e affidare a ciascuno di loro una canzone diversa affinché la potessero trasporre in un racconto è qualcosa di più complesso di una pura operazione filologica o storiografica: è piuttosto tracciare uno storico del cuore, per mapparne le stratificazioni successive, dagli anni Novanta a oggi.
A me insomma, piace dirla così: abbiamo voluto capire fino a che punto si potesse fare del grunge uno “stile letterario”.
Non volevo sgranare l’ennesimo rosario di storie e aneddoti intorno alla figura di Cobain: volevo emergesse quello che eravamo (e che siamo) noi a contatto con quelle distorsioni e con quei testi.
Questo unito anche al fatto che, come dice bene Andrea Pomella, uno scrittore che è stato un po’ la mia “musa barbuta” (con il suo “Anni luce” ha fatto un’operazione meravigliosa di recupero alla Storia di un tempo spesso considerato una sorta di buco nero), manca, almeno in Italia, una narrazione organica della generazione grunge degli anni Novanta. E manca, con l’eccezione di Pomella stesso, una voce che si sia fatta carico di raccontare tutte quelle contraddizioni, quel marasma di azioni insignificanti, impegno, rabbia, devastazione e tenerezza che contraddistinto una lunga generazione. E che ne ha condizionato altre.
Vista dai libri di Storia, la storia dei Novanta è stata solo un campionario di guerre. Noi ci siamo ribellati a questo luogo comune. Ribellare è la cosa che ci è riuscita meglio in fondo, pure che quasi mai le nostre lotte sono state vittoriose.
Quali sono state le difficoltà che hai riscontrato nel lavorare con 25 persone?
Quelle che si riscontrano tutte le volte che lavori con gruppi eterogenei di persone: il rispetto delle consegne. D’altronde, pretendere disciplina su un qualcosa che si ispira al genere musicale più indisciplinato (con il punk) d’ogni epoca sarebbe stato troppo. E, aggiungo, forse anche fuorviante.
C’è poi da dire che, se con la maggior parte degli autori ci sono rapporti consolidati, con altri è stato un primo approccio e dunque non sapevo esattamente cosa aspettarmi e cosa no. Per un momento, è stato come essere il protagonista di uno di quei videogame platform da lido o consolle, e mi sono ritrovato a saltare da una nuvola all’altra con la sensazione di poter cadere giù nel fosso da un momento all’altro.
E quali sono stati i momenti piacevoli?
Tutti, compresi quelli più difficili. Anzi, in prima battuta quelli più difficili. Pensavo che avere in mano il prodotto finito sarebbe stata l’emozione più grande. E invece è stata proprio quell’adrenalina del lavoro, quella di cui dicevo prima, quel rapporto lungo un anno e mezzo con gli autori, a generare le sensazioni più autentiche e potenti.
Se però dovessi sceglierne uno specifico, di momento, è stato quello in cui, a racconti arrivati e a “scaletta decretata”, prima di leggerli di filato, ho messo in fila le 25 canzoni così come risultavano, scompigliate, e mi sono lasciato trascinare senza salvagente in cinque anni di grunge.
A quale associazione e perché la scelta di devolvere in beneficenza i proventi della vendita di questo testo?
Kurt Cobain è stato un elemento di rottura all’interno della scena musicale rock. Con lui l’approccio machista “dell’oh baby”, il riferimento alla donna come oggetto di desiderio o, al massimo di dolore, va in frantumi. In Cobain la donna assume tutta una complessità che il rock fino ad allora non aveva contemplato: diventa mamma, diventa amica, diventa vittima, diventa compartecipe, diventa protagonista. Rispetto alla questione femminile, potremmo dire che Cobain sta alla musica rock come Fabrizio De André sta al cantautorato. Le donne dei testi dei Nirvana escono insomma dal binario unidimensionale “dell’essere musa”. Le donne esplorate e raccontate dai Nirvana sono donne che – e torno un po’ all’inizio – fanno parte del mondo, contaminano e si contaminano con l’amore come con la violenza.
Si tratta di una questione di genere?
Assolutamente sì. Lo stesso Cobain si dichiarava, e lo faceva apertamente, insicuro sulla sua inclinazione sessuale. E alimentava il suo lato femminile anche con l’immagine. C’è una foto, una delle più belle, in cui veste un abitino a fiori, che è la sintesi iconografica di quando fin qui detto: perché Kurt in quegli abiti non sta allestendo un personaggio, si sente a suo agio.
Nel booklet di “Incestide”, album della fine del 1992, si legge: “Se qualcuno di voi, in qualche modo, odia gli omosessuali, le persone di colore diverso o le donne, per favore lasciaci da soli. Non venire ai nostri concerti e non comprare i nostri album”.
Ecco. Nell’ottica di questo ragionamento si pone la scelta di devolvere tutti i nostri diritti d’autore al Gruppo Abele, associazione torinese fondata da Luigi Ciotti oltre 50 anni fa sulla strada. In particolare, sosterranno un progetto specifico che si chiama Drop House che accoglie, in bassa soglia, donne che vivono una situazione di vulnerabilità. Il tutto, in un quartiere complesso come Barriera di Milano, storicamente approdo di migrazione.
Hai un racconto che ti è piaciuto più degli altri, oltre al tuo?
Ogni racconto ha un suo significato. Ogni racconto ha il suo stile. Ogni racconto condensa, proprio come fa il grunge, effluvi acri e dolci in poco tempo. Non posso sceglierne uno. Un po’ per fair play, un po’ per paraculaggine, un po’ per questa unicità.
Perché proprio Kurt Cobain?
Perché Kurt Cobain è stato il nostro primo approccio con la verità. Dura come un pavimento di marmo sul muso ma tant’era. Kurt Cobain ha segnato, per molti di noi, il confine da varcare per arrivare alla consapevolezza: attraverso la ribellione o attraverso la riflessione, a seconda del carattere di ognuno. Con il primo ascolto dei Nirvana si entrava, giocoforza, in uno spazio nuovo dove valevano regole più grandi di quelle che vigevano nel regno dei ragazzi. Non bastava più tirare a sorte e far scegliere con i “Ponte ponente ponte pì” o agli “Ambarabà ciccì coccò”.
Con un gioco di parole possiamo dire che il “passaggio di rito”, tra amici, delle cassette dei Nirvana erano una sorta di “rito di passaggio” (lo sono ancora, cambia il supporto). Ci sono state le generazioni dei cineforum, noi siamo stata quella del grunge: discutevamo di mondo citando i testi dei Nirvana, dei Soundgarden, dei Pearl Jam. I più “specializzati” degli Alice in Chains o dei Temple of the Dog. Quelle parole, in definitiva, erano le parole che avremmo voluto dire noi e che non riuscivamo a dire.
Urla comprese.
Grazie a Piero per essere stato con noi!