Solo qualche giorno fa, è uscita qui su libri.iCrewplay, la recensione che ho scritto con molto piacere dopo aver letto il libro Pècmén di Fabrizio Venerandi. Un libro che ho apprezzato moltissimo ma che, come già scritto nei paragrafi dell’articolo precedente, mi ha lasciato qualche domanda aperta da porre direttamente all’autore.
Così è stato, quindi ringraziando Fabrizio Venerandi per la disponibilità e la celerità nel rispondere alle mie domande, non mi dilungo molto e ti lascio, caro iCrewer, all’intervista vera e propria:
INTERVISTA A FABRIZIO VENERANDI
Come già scritto durante la recensione, ho letteralmente bisogno di un aiuto per sciogliere un nodo che da sempre c’è nel mio pensiero, figlio della mia ignoranza e dei miei limiti: come si sposano, come convivono un programmatore e uno scrittore? Nella mia idea uno è freddo e calcolatore, l’altro caldo ed emotivo… quindi, in soldoni, che analogie ci sono tra programmare e scrivere?
Io credo che il piacere della programmazione e il piacere della scrittura abbiano dei punti in comune. C’è in entrambi il lavoro su qualcosa che piano piano prende forma, composto di diverse parti che devono trovare tra di loro corrispondenze e che – alla fine – diventano un prodotto autonomo che “fa qualcosa” quando viene utilizzato. Scrivere codice è appassionante, ti consuma, ci pensi e ci ripensi, affini il codice, lo ottimizzi, editi e puoi lavorare a un progetto per anni, un po’ come avviene con la scrittura.
E con la poesia come la mettiamo? Visto che Fabrizio Venerandi è anche un poeta?
Il collegamento con la poesia è ancora più forte. Nel 2016 ho pubblicato un ebook intitolato Poesie Elettroniche, dove le singole poesie sono scritte in versi, ma anche programmate in codice. Il coding diventa un ulteriore strumento di retorica, per far fare alle poesie cose che altrimenti non potrebbero fare sulla carta: cambiare nel tempo, rispondere alle sollecitazioni del lettore, muoversi nello spazio, cancellarsi mentre le si leggono.

Come è nata l’idea di Pècmén?
Nel 2007 avevo iniziato a pensare ad un libro che parlasse degli anni ottanta, utilizzando i videogiochi come filo conduttore di un racconto che fotografasse l’arrivo dell’informatica, degli home computer, dei videogame in un paese di provincia. Leggevo in giro articoli e libri costruiti attorno ai mitici anni sessanta, del sessantotto, degli anni settanta, mentre gli anni ottanta erano visti come un decennio di decadenza, fasullo, in cui si era persa una generazione.
Ecco, il libro è nato per mostrare che anche in quel decennio sono emerse cose che hanno modificato la contemporaneità, il modo di percepire se stessi come generazione e la realtà che ci circonda. Anzi, forse gli anni ottanta sono il decennio in cui è più facile trovare alcuni fili delle estetiche e degli immaginari quotidiani, a partire dal digitale e – appunto – dalla visione del mondo come un enorme esercizio di gaming e di gamification.
Quanto c’è oggi In Fabrizio Venerandi di tutte le versioni dei Fabrizi di cui si parla nel libro? È rimasto qualcosa o anche in età adulta si genera una nuova versione di noi stessi?
È una bella domanda. Il Fabrizio di oggi ha cinquant’anni ed è sbalordito di questa cosa perché sotto la scocca trova ancora un grosso ammasso di casini adolescenziali, che – a questo punto – non erano tali. Si hanno delle idee stereotipate di quello che saremo a trenta, quaranta, cinquanta anni e oggi mi rendo conto di come tutta l’immaturità dei Fabrizi vissuti negli anni passati hanno generato un nuovo meraviglioso, immaturo, Fabrizio cinquantenne.
Perché, dal testo, sembra che ci sia un giudizio negativo sugli anni ’80?
No, non credo che sia un giudizio negativo sugli anni ottanta; non è un giudizio artefatto, questo è vero. In Pècmén ho cercato di evitare la nostalgia superficiale che vedo in giro in tanta fiction streaming o nei meme dei social. Ho cercato di mostrare quello che un ragazzino adolescente trovava attorno a sé: la confusione, la sovrapposizione di valori e di estetiche, il sesso.
Centipede, Mike Buongiorno, l’ANPI, l’assassinio di Moro, Lupo Solitario, i paninari, Le Ore e tanti altri condividevano gli stessi spazi e gli stessi tempi. C’erano tutte queste cose e rimuoverne alcune per rendere più mitici gli anni ottanta è un esercizio di autodifesa che non mi appartiene. Io sono stato tutte queste cose, anche le più vergognose e dolorose.
Quale decennio, di quelli che ovviamente abbiamo vissuto, allora è il più ricco? Quello che davvero ha contribuito a formarci e farci essere chi siamo?
Oh, tutti. Io credo ancora oggi di continuare a formare il Fabrizio Venerandi che è dentro di me, per me ogni giorno è un continuo insegnamento. Ci sono un sacco di cose da imparare che vengono fuori dalla rete, dalla storia. La divisione in decenni è un po’ una facilitazione che facciamo per semplificarci la vita, ma in realtà non esiste. Siamo un enorme lombrico che mangia terra incessantemente e dall’altra parte produce.
Tornando a quegli anni, quelli di Pècmén, cosa direbbe oggi Fabrizio Venerandi a quei ragazzini, potendo tornare indietro nel tempo per incontrarli in quella piazza?
Ho un aneddoto che non ho scritto nel romanzo. Ero un ragazzino di una decina di anni ed ero sceso fino al campo da calcio del Sant’Olcese e mi ero seduto su una serie di tubi metallici che erano laggiù.
Per non conosce il posto, il campo del Sant’Olcese è costruito su un piccolo budello di strada che finisce nel nulla, è circondato dal nulla, e dove – in genere – non c’è nessuno.
Invece quel giorno seduta sui tubi c’era una signora che non avevo mai visto prima nella mia vita che inizia a parlami, mi chiede chi sono, che faccio in quel posto, insomma dopo un po’ mi dice che lei è molto anziana e io molto giovane e che avrebbe un insegnamento da darmi.

Dice che avendo vissuto molto tempo aveva capito molte cose della vita e ora aveva un insegnamento che mi sarebbe stato molto utile quando sarei stato grande.
Ma poi – aggiunge – sarebbe inutile darmelo perché poi lo avrei dimenticato, ero davvero troppo piccolo, tempo di diventare adulto me lo sarei dimenticato.
“No signora – dissi io – le prometto che non dimenticherò mai questo momento” e veramente incisi nella mia memoria di bambino quel momento e quel breve dialogo avuto con la signora, la quale mi sorrise e mi disse, va bene, allora ti dirò questo insegnamento.
Lì si ferma il mio ricordo. Non ricordo assolutamente nulla di quello che successe da quel momento in poi. Niente di quell’insegnamento che la signora mi disse quel giorno, sui tubi di metallo vicino al campo da calcio del Sant’Olcese.
Forse spossato dall’aver impresso nella mia mente la promessa di non dimenticare, per sempre, avevo esaurito lo spazio per il resto.
E mi resta il dubbio che l’insegnamento fosse stata una sciocchezza che avevo immediatamente rimosso, o che io abbia ascoltato e introitato quel breve messaggio e che la mia vita sia rimasta davvero modificata da quel dialogo, che abbia assorbito quel pezzo di vita come si assorbono certe ferite quando si cade dalla bicicletta.
Ecco, se tornassi indietro nel tempo sarei come quella signora, terrorizzata di lasciare qualcosa di indelebile in piccole forme in continua evoluzione, cancellazione, creazione, rimozione.
La nostra generazione, io ho poco più di quaranta anni, ha mantenuto le aspettative create in quegli anni?
Per quanto riguarda il digitale no. Penso che negli anni ottanta si avesse una idea dell’informatica e della telematica molto coraggiosa. Prevedeva che una parte del mondo sarebbe migliorata per poter usare il digitale. Avrebbe imparato un alfabeto comune per poter dominare questa rivoluzione industriale in corso. Poi è emersa una seconda filosofia, ovvero che i computer dovessero essere usati da tutti, a prescindere dalla loro capacità di usarli. I computer come le lavatrici.
Si è creata, di nuovo, una separazione tra chi è produttore di contenuti digitali e chi invece consuma e per stare nel digitale deve continuare a non conoscere le macchine che usa, deve solo consumare. Alla fine l’informatica e la telematica oggi fanno enormi sforzi di ciclo e spostamento dati per gestire junk food digitale.
Nel libro c’è un bellissimo capitolo dedicato ai libro-game. Mai pensato di scriverne/progettarne uno, o pensi siano ampiamente superati?
Oh, l’ho fatto.
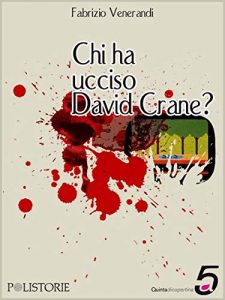
Nel 2010 ho programmato un ebook intitolato Chi ha ucciso David Crane? che è un romanzo post moderno scritto con la stessa tecnica a bivi dei librogame. E ancora nel 2018 ho pubblicato un ebook breve intitolato Mens e il regno di Axum che inizia proprio come un librogame fantasy ma poi – man mano che si va avanti nella lettura – il gioco collassa e ci si ritrova a camminare all’interno della mente dello scrittore, alla sua incapacità di fare fiction, ai suoi problemi del mondo reale. Penso che il librogame e la letteratura elettronica in genere (compresi i videogame) siano una delle cose grosse del futuro, altro che superati.
Da più soddisfazione terminare un romanzo o completare un software?
È molto diverso. Un software è più facile capire se funziona o no. Spesso se non funziona si ferma e dà errore. Il romanzo nel momento che lo termini e lo pubblichi, resti lì appeso, ad aspettare di capire se gira davvero bene oppure no. Tu hai una percezione, ma non ne sei sicuro.
Dovendo partire per un’isola deserta, meglio un libro o un videogioco? Supponiamo entrambi, quali?
Videogioco penso che mi porterei dietro Kentucky Route Zero, perché è un capolavoro della narrativa elettronica e mi piacerebbe rifarlo tutto scegliendo i percorsi che non ho fatto la prima volta. Libro, penso che mi porterei i volumi dell’edizione bianca del Materiale e l’immaginario. È un testo che ho scoperto recentemente e l’ho trovato molto “digitale” come concezione. Penso che sarebbe un’ottima lettura da isola deserta.
Concludendo, si sta già lavorando a qualche nuova idea?
Tante. Troppe. Ne dico solo una: un saggio breve sulla letteratura non lineare.
Rinnovando i ringraziamenti a Fabrizio Venerandi, e confermando anche dopo questa intervista i complimenti per tutto il suo lavoro che si divincola tra fogli di carta e fogli digitali, almeno così mi piace immaginarlo, ti invito, caro iCrewer, a leggere Pècmén perché è un romanzo davvero curioso e ricco di spunti molto interessanti per aprire i cassetti della memoria.