Non soffriremo il caldo quest’estate, amico lettore: brividi e suspense sono assicurati. Tra le novità che presto compariranno tra gli scaffali delle librerie vi sono due attesissimi titoli, nati dalla penna di Massimo Carlotto e Gianluca Arrighi; Variazioni sul noir e Intrigo in Costa Verde.
Ecco il comunicato stampa che ci è arrivato in redazione

Massimo Carlotto e Gianluca Arrighi stanno per tornare in libreria con due titoli attesissimi: Variazioni sul noir e Intrigo in Costa Verde. In quest’ultimo, Arrighi ha dato i natali ad un nuovo personaggio letterario, l’avvocato penalista Alex Manfredda, che i lettori non vedono l’ora di conoscere.
Si preannuncia pertanto un’estate nel segno del giallo in compagnia di due maestri indiscussi del brivido. Le uscite in libreria, previste a giugno e a luglio, rappresentano i titoli di punta per i tipi di “Nero noir”, la nuova collana della CentoAutori che offre viaggi emozionanti, storie misteriose e intrighi mozzafiato, sfidando l’acume di chi legge per giungere alla scoperta della verità e assicurare alla giustizia i colpevoli, il tutto declinato secondo le tinte del giallo, del thriller e del poliziesco. Con l’arrivo dell’estate, d’altronde, le vendite di romanzi thriller e mistery subiscono un’impennata, confermando come questo genere letterario sia da sempre il più apprezzato dai lettori di tutto il mondo.Massimo Carlotto e Gianluca Arrighi
Ed eccoti caro iCrewer una chicca tutta per te, un estratto da Crimina Romana, che Arrighi ha gentilmente messo a disposizione dei suoi fan tramite la sua pagina Facebook. Buona lettura!
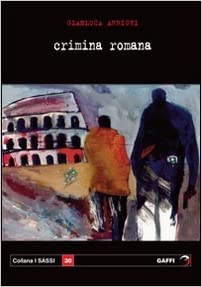 “IL BOSS DECADUTO
“IL BOSS DECADUTO
Franco Cisnetti, detto “er Tintore”, era stato sino alla fine degli anni ’90 un esponente di spicco della criminalità organizzata. Dico “era stato” perché Franco aveva ormai perso molto del potere che deteneva in passato e, come spesso accade, proprio in coincidenza del suo indebolimento era finito in manette. Prima che cominciasse il suo declino, annunciato da un paio di affari andati in malora, “er Tintore” incuteva rispetto. Rispetto e paura.
La malavita è come una casa di vetro intorno alla quale, in circolo, volano decine di avvoltoi pronti a cogliere l’attimo, a scendere in picchiata per infliggere il colpo di grazia, sostituire, arrestare. Cisnetti, da ragazzo, era già finito due o tre volte dietro le sbarre, ma bene o male era sempre riuscito a sopravvivere all’esperienza carceraria che anzi sembrava averlo reso ancora più forte. Non aveva alcuna intenzione di redimersi. Per lui la galera era stata una vera e propria scuola e aveva approfittato dei periodi trascorsi in gattabuia per raffinarsi, perfezionarsi, estendere le relazioni sociali per l’ascesa della sua carriera criminale.
Sino alla fine degli anni ’60 la malavita romana era strutturata in piccoli gruppi, ognuno padrone del proprio territorio. I “boss” di quartiere, tra cui Franco, vivevano di piccoli furti, gioco d’azzardo, contrabbando di sigarette e sfruttamento della prostituzione. I contrasti si risolvevano ancora a coltellate. Le grandi rapine avvenivano quasi esclusivamente nell’Italia del Nord ed erano compiute da bande organizzate in modo militare.
A Roma si respirava ancora una sorta di età dell’innocenza, era una mala “casereccia”, un po’ come quella descritta nei primi romanzi di Pasolini. Il grande cambiamento avvenne quando, poco prima della metà degli anni ’70, nella Capitale vi fu l’avvento dei Marsigliesi, la banda di gangster italofrancesi. Con loro giunse anche l’eroina e un gran movimento di denaro. I “boss” romani fiutarono subito l’affare adeguandosi a quella nuova e “scientifica” forma di criminalità. Nell’ambiente malavitoso Franco Cisnetti si era guadagnato quel soprannome, “er Tintore”, grazie alle sue riconosciute capacità di ripulire i soldi sporchi.
Da allora era trascorso tanto tempo. Adesso il “boss” si trovava ristretto nel carcere penale di Rebibbia. Anche in questa occasione, tutto sommato, aveva accolto abbastanza bene l’ordinanza di custodia cautelare che lo aveva raggiunto nella sua bella casa di Positano, la “casetta” come la chiamava lui. L’abitazione si trovava su una collina così ripida che avevi l’impressione di essere su un precipizio se non vi fossero state intagliate delle scale. Franco, scherzando, amava ripetere come le fondamenta delle case, di solito verticali, a Positano fossero state costruite orizzontalmente.
Dalla sua camera da letto si poteva scorgere il golfo sinuoso dall’acqua verde e azzurra che bagnava una spiaggia di piccoli ciottoli. Stavolta, tuttavia, avrebbe dovuto abbandonare quell’angolo di paradiso. Il processo si era concluso. “Er Tintore”, giunto ormai sulla sessantina, doveva espiare una condanna a 18 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata all’estorsione e al riciclaggio. La Cassazione aveva definitivamente confermato la sentenza e mi stavo recando in carcere per comunicare a Cisnetti la notizia.
Ero in auto, e riflettevo su come ormai fossero trascorsi dieci anni da quando avevo iniziato a esercitare la professione di avvocato. Una volta terminato il tirocinio e superato l’esame di Stato, avevo iniziato subito a lavorare in proprio. La mia vita, come quella di quasi tutti gli avvocati penalisti, si svolgeva quotidianamente tra le aule di tribunale, gli uffici giudiziari, le caserme dei carabinieri, lo studio legale e le case circondariali.
Contrariamente a quanto si possa credere, è una professione faticosa quella dell’avvocato. Specie per chi, come me, è un avvocato “primario”, ossia di prima generazione. Gli inizi della carriera si caratterizzano soprattutto per l’estrema difficoltà di trovare clienti disposti a dare fiducia (e denaro) a un giovane avvocaticchio “sbarbato”.
Poi, se le cose vanno bene, subentrano le prime soddisfazioni. E con esse le enormi responsabilità, la gestione della clientela, le pubbliche relazioni, il costante aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale, i contatti con la stampa, l’assunzione di validi collaboratori, il sentirsi “drogato” dal lavoro, il numero sempre maggiore di udienze e di processi da seguire, la consapevolezza di non avere il “diritto di ammalarsi”, dover pensare di continuo ai casi da risolvere, anche quando si dorme.
Lo stress è notevole, bisogna farci l’abitudine. E paradossalmente, quando si verificano tutte queste condizioni, l’avvocato può ritenersi soddisfatto del suo lavoro. Mi ero da poco sposato con Giulia che, oltre ad essere la madre delle mie figlie, condivideva con me la passione per l’avvocatura, seppur in un settore diverso. Giulia è una civilista e dopo il matrimonio, con immensi sacrifici, avevamo aperto il nostro studio legale.
Posteggiai l’auto praticamente di fronte all’ingresso principale del carcere di Rebibbia. Mi venne in mente come quel luogo così infelice per i tanti detenuti che vi erano ristretti fosse, per contro, uno dei pochi posti nei quali a Roma si poteva ancora trovare un parcheggio decente.
Mentre effettuavo le rituali procedure di identificazione e di riconoscimento che si eseguono per accedere al carcere, mi ricordai di quando il figlio del “Tintore”, un bravo ragazzo appena diplomatosi geometra, al termine di uno dei tanti processi in cui avevo assistito il padre, mi telefonò e disse: “Avvocato, papà in fondo è un uomo buono. So che sembra impossibile e so che si è macchiato di crimini orrendi, ma la vita non gli ha dato alternative.”
Nonostante i loro rapporti fossero conflittuali, quel giovane voleva molto bene a suo padre. Solo lui, nella famiglia, continuava a interessarsi alle vicissitudini giudiziarie di Franco. In quella occasione pensai che in realtà tutti i criminali sono fautori consapevoli delle proprie scelte e come la solita storia di non poter percorrere un’esistenza all’interno della legalità fosse solamente un alibi dovuto al senno di poi. Eppure avevo lo stomaco contratto, mi pesava dover dire a quell’uomo che, di fatto, avrebbe trascorso in carcere il resto della sua vita.
Erano circa quindici minuti che attendevo nella sala avvocati quando l’agente di custodia mi chiamò per dirmi che Cisnetti era arrivato, “tradotto per il colloquio con il difensore”, come si dice in gergo. Ci sedemmo l’uno di fronte all’altro. Franco era ben vestito, come sempre. Ma aveva un’aria seria, preoccupata. Ci guardammo negli occhi e restammo in silenzio. Non ci fu bisogno di parole. L’uomo sospirò e disse: “Avvocà, io nun ce resto qua dentro. Vojo morì libero, mentre guardo er mare.”
Nei mesi successivi “er Tintore” mi scrisse dal carcere molte lettere alle quali cercavo, per quanto possibile, di rispondere sempre in modo tempestivo. Dalle missive trasparivano, con estrema sobrietà e contegno, tristezza, rabbia, sconforto. Tuttavia rimasi sorpreso di come, nelle parole di Cisnetti, non vi fossero mai rassegnazione o autocommiserazione. Quella condanna definitiva a 18 anni di reclusione sembrava aver scalfito, ma non distrutto, la corazza che la vita e la strada gli avevano cucito addosso.
Qualche tempo dopo lessi sul giornale una notizia che mi lasciò di stucco. “Er Tintore” era stato dichiarato latitante ed era indagato in un nuovo procedimento penale per i reati di frode processuale e falsa perizia determinata dall’inganno altrui. Secondo il pubblico ministero, Franco Cisnetti avrebbe “assunto oralmente specialità farmaceutiche contenenti bacilli del ceppo vaccinale Mycobacterium bovis BCG per risultare positivo all’esame dell’espettorato e così vedersi diagnosticata una tubercolosi polmonare che avrebbe reso le sue condizioni incompatibili con il regime carcerario.”
In sostanza avrebbe masticato un vaccino antitubercolare ogni volta che doveva sottoporsi a una visita medica. Il BCG è un vaccino per la tubercolosi che viene prescritto solo per alcune categorie a rischio, come gli operatori sanitari. Non è un vaccino molto efficace, ma, ovviamente, chi ha assunto il BCG può presentare una reazione positiva al test tubercolinico.
Ecco cosa accadde.
Cisnetti dichiarò agli operatori penitenziari di sentire forti dolori al torace e di avere difficoltà respiratorie. Chiese quindi di essere visitato da uno specialista. Venne nominato un perito per accertare le sue condizioni di salute e un medico, un luminare del settore, diagnosticò proprio la tubercolosi. A qual punto per Franco si schiusero le porte del carcere. Ma il pubblico ministero, magistrato attento e caparbio, non ci vide chiaro e dispose un’altra perizia.
Il nuovo esame tecnico giunse clamorosamente a conclusioni opposte. La malattia era finta, temporanea. Insomma, così come era arrivata, poteva sparire. Era solo la conseguenza del vaccino masticato e ingoiato da “er Tintore” prima delle visite mediche. Sulla scia infinta delle polemiche e delle inchieste che seguirono su come fosse stato possibile far avere a un detenuto il vaccino della tubercolosi, venne emesso un nuovo ordine di carcerazione per Franco. Ma ormai era troppo tardi.
Io non lo vidi più. Suo figlio non lo vide più. Nessuno, sembra, lo vide più. Leggende metropolitane narrano però di un italiano con i capelli bianchi che ancora oggi, sulle spiagge di Varadero, a Cuba, beve mojito raccontando strane e appassionanti storie sulle vicende giudiziarie del nostro Bel Paese.”