Apriamo questo numero di Filosofiamo con un indovinello: “Qual è il suono di una mano sola che applaude?”. Se la tua prima reazione è stata “ma non ha senso!”, congratulazioni: hai appena incontrato il tuo primo kōan. E se la tua seconda reazione è stata cercare di risolverlo logicamente – forse è il suono del vento, o del silenzio, o della mano che si muove nell’aria – beh, hai sbagliato. Ma non preoccuparti: sbaglierai ancora per anni, forse per decenni. E proprio questo è il punto.
Benvenuti nel mondo bizzarro, frustrante e stranamente liberatorio del kōan zen! L’unico sistema filosofico che ti dice esplicitamente che stai pensando troppo e che dovresti smettere immediatamente. Ma siccome sei umano, continuerai a pensare. Ed è esattamente lì che inizia il divertimento.
Kōan Zen: quando la logica va in vacanza
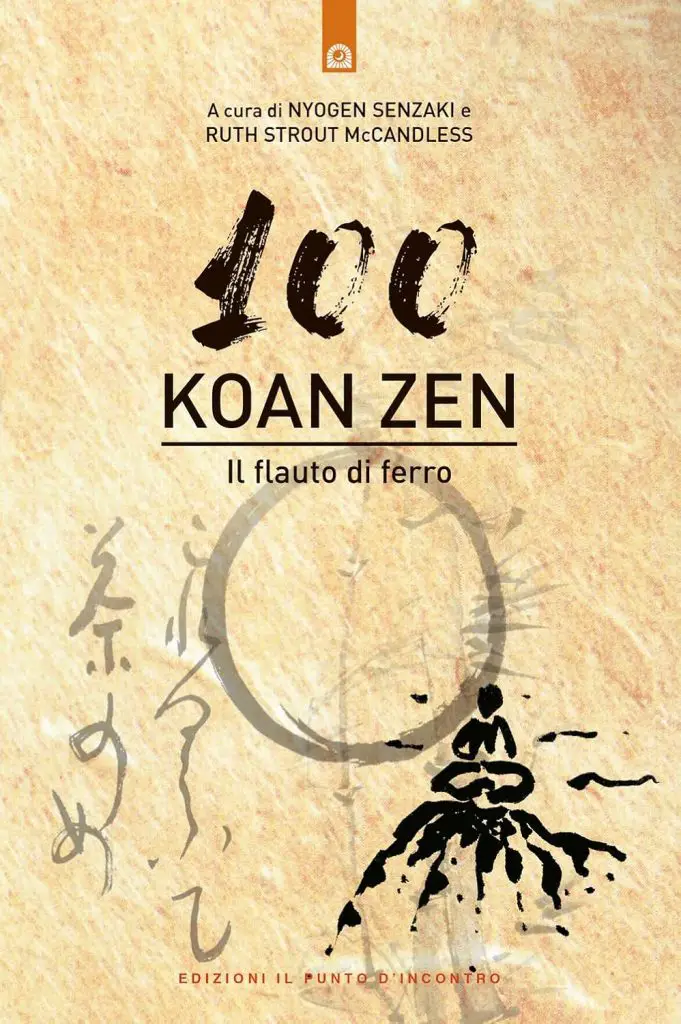
Un kōan è un enigma, una domanda, una storia breve – di solito basata su un dialogo tra un maestro zen e un allievo – che ha la caratteristica fondamentale di essere irrisolvibile attraverso il ragionamento logico. Non è un indovinello con una risposta nascosta. Non è un problema da decifrare. È un cortocircuito volontario del cervello, un sabotaggio premeditato del pensiero razionale.
Il termine kōan viene dal cinese kung-an, che originariamente significava “caso pubblico” o “editto governativo” – un documento ufficiale dell’impero cinese. Che c’entra un documento burocratico con l’illuminazione? Apparentemente nulla, ma proprio questo è lo spirito zen: prendere qualcosa di completamente ordinario e trasformarlo in strumento di risveglio. Un “caso pubblico” diventa un “caso” spirituale che chiunque può esaminare, ma che nessuno può chiudere con un verdetto razionale.
I kōan vengono usati principalmente nella scuola zen Rinzai, fondata in Giappone nel XII secolo dal monaco Eisai. Questa scuola crede nell’illuminazione improvvisa – il famoso satori – che arriva come un lampo quando la mente smette di cercare di capire e semplicemente vede. Il kōan è lo strumento chirurgico progettato per provocare questo lampo. È un bisturi che taglia attraverso gli strati di pensiero concettuale per arrivare a qualcosa di più diretto, più immediato, più vero.
Facciamo un tour veloce di alcuni dei kōan più celebri! Ne puoi trovare altri ne Il flauto di ferro del maestro Nyogen Senzaki.
Chi ti ha incatenato? Un giovane si presenta al maestro: “Vengo da te perché cerco la liberazione”. Il maestro chiede: “Chi ti ha incatenato?”. Il giovane risponde: “Nessuno”. “Allora sei già libero”, conclude il maestro. Fine della storia. Ma se sei già libero, perché stai cercando la liberazione? E se nessuno ti ha incatenato, perché ti senti prigioniero? Buon divertimento a dormire stanotte.
Il suono di una mano sola. Il maestro Hakuin, nel XVIII secolo, rese famoso questo kōan: “Battendo le mani l’una contro l’altra si produce un suono. Qual è il suono di una sola mano?”. C’è una storia bellissima su un bambino di otto anni che ricevette questo kōan dal maestro. Il bambino tornò ogni giorno con una risposta diversa: il vento, la pioggia, il canto degli uccelli. Il maestro scuoteva sempre la testa. Dopo mesi di tentativi, il bambino disse: “L’ho sentito, ma è privo di suono”. Solo allora il maestro annuì.
La tazza di tè troppo piena. Un filosofo va da un maestro zen e dice: “Sono venuto per conoscere lo Zen”. Il maestro inizia a versargli del tè. Quando la tazza è piena, continua a versare. Il tè trabocca sul tavolo. “Ma cosa fai?” protesta il visitatore. “Non vedi che è piena?”. “Come questa tazza”, risponde il maestro, “la tua mente è troppo piena di opinioni. Come posso versarci dentro qualcos’altro?”. Questo non è tecnicamente un kōan classico ma ha la stessa funzione: rovesciare le tue certezze. Prima svuoti la tazza, poi possiamo parlare.
Il grande dubbio e il paradosso dell’apprendimento

In questo ultimo kōan risiede tutto il senso di questa pratica filosofica. Il koan non può essere insegnato, ma deve essere praticato. Così come l’acqua che fuoriesce dal bicchiere questa pratica non può essere semplicemente inculcata a forza, ma va affinata con lo studio, la meditazione e la riflessione così da “svuotarsi” sempre di più.
Nella tradizione Rinzai, l’allievo riceve un kōan dal maestro e lo porta con sé ovunque: mentre medita, mentre lavora, mentre mangia. Il kōan diventa un’ossessione, una domanda che non lo abbandona mai. Poi, regolarmente, l’allievo va dal maestro per un colloquio privato chiamato dokusan o sanzen e propone la sua “risposta”. Il maestro, nella maggior parte dei casi, lo manda via con un secco “sbagliato”. Questo può andare avanti per anni.
Questo serve non a dare certezze ma a disgregarle. Il maestro Hakuin diceva che per praticare lo zen servono tre cose: la grande fede, il grande dubbio e la grande determinazione. Il kōan è progettato per instillare questo grande dubbio. Non un dubbio scettico o cinico ma un dubbio totale, bruciante, che consuma ogni certezza. Dubiti della logica. Dubiti del linguaggio. Dubiti della tua stessa capacità di comprendere il mondo.
Finché credi di poter “capire” l’illuminazione, finché pensi che sia un concetto da afferrare, un problema da risolvere, un obiettivo da raggiungere – resterai bloccato. Il kōan ti porta deliberatamente in un vicolo cieco. Ti mette davanti a un muro. E quando finalmente smetti di cercare un passaggio attraverso il muro, quando ti arrendi completamente, quando accetti che non c’è risposta… a volte il muro scompare.
Il kōan della vita quotidiana

Quindi qual è il suono di una mano sola? Se ancora stai cercando una risposta a questo enigma probabilmente ti è sfuggita la sua essenza.
Il kōan non è lì per essere risolto. È lì per spezzare l’illusione che tutto debba essere risolto. Viviamo in una cultura ossessionata dalle soluzioni, dalle risposte, dalle spiegazioni. E per cercare tutto questo finiamo intrappolati in una rete di paradossi: siamo più connessi che mai ma ci sentiamo soli. Abbiamo accesso a tutta l’informazione del mondo ma non sappiamo più cosa sia vero. Lavoriamo per vivere ma non abbiamo tempo per vivere. Cerchiamo la felicità ma ogni strategia per ottenerla sembra renderla più sfuggente.
Il kōan ci dice: “E se non ci fosse niente da capire? E se la comprensione stessa fosse il problema?”.
Non serve diventare tutti monaci zen e passare vent’anni a meditare su enigmi impossibili. Ma forse, solo forse, c’è qualcosa di prezioso nell’idea di lasciare andare occasionalmente il bisogno di capire tutto. Di stare seduti con un paradosso senza cercare immediatamente di risolverlo. Di accettare che alcune domande non hanno risposte – e che questo non è un difetto del mondo ma una sua caratteristica fondamentale.
Il maestro zen contemporaneo Shunryu Suzuki disse una cosa bellissima: “Nella mente del principiante ci sono molte possibilità, nella mente dell’esperto ce ne sono poche”. Il kōan è un modo per tornare alla mente del principiante. Per vedere il mondo come se lo vedessimo per la prima volta, senza tutte le spiegazioni e le categorie che abbiamo accumulato.
In conclusione: quando la logica non funziona più, quando le risposte abituali non soddisfano, quando ci troviamo davanti a qualcosa di fondamentalmente irrisolvibile – abbiamo due opzioni. Possiamo continuare a sbattere la testa contro il muro, sempre più frustrati. Oppure possiamo fare quello che suggerisce il kōan: fermarci, respirare, e chiederci se forse il problema non è nel mondo ma nel modo in cui lo stiamo guardando.