Viviamo in un’epoca in cui il pensiero positivo è diventato quasi un imperativo morale. Ci viene detto di visualizzare i nostri obiettivi, di “manifestare” i nostri sogni, di credere che l’universo risponda alle nostre vibrazioni. Ma quanti sanno che tutto questo affonda le sue radici in una filosofia spirituale nata più di un secolo fa? Questa domenica filosofica è quindi dedicata al movimento New Thought, “Nuovo Pensiero” che oggi sta conoscendo una seconda giovinezza.
Il New Thought: la storia
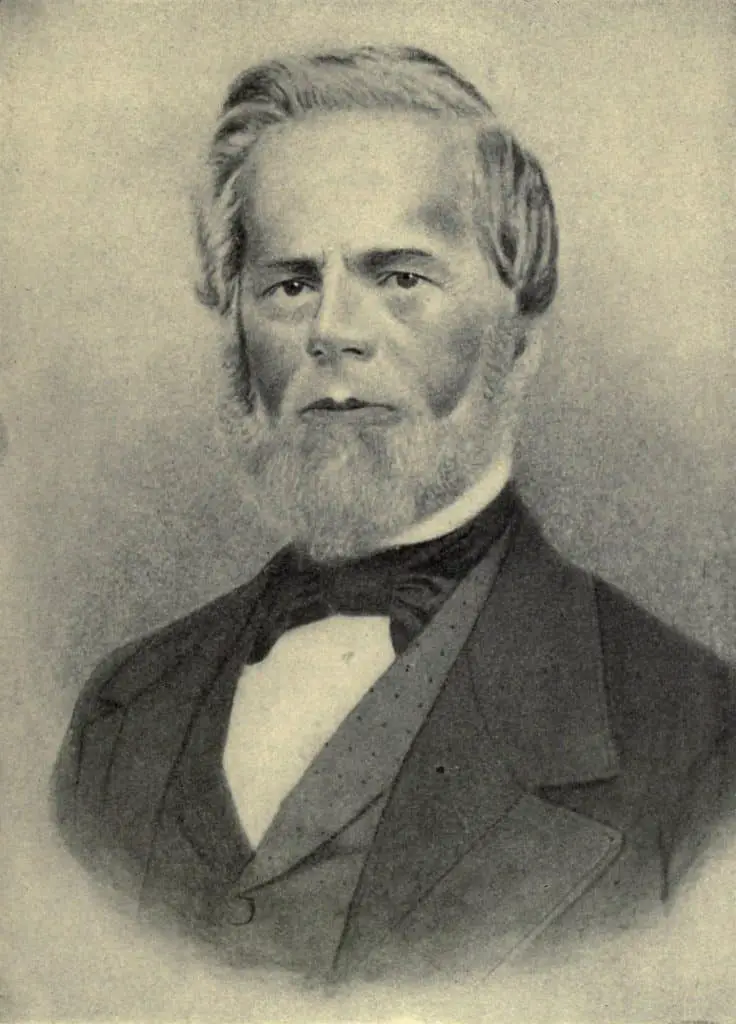
Il New Thought nasce nell’America dell’Ottocento, in un periodo di fervore religioso e di grandi trasformazioni sociali. È figlio di un tempo in cui la fede e la scienza cercavano di parlarsi, in cui l’anima e la mente sembravano poter finalmente trovare un linguaggio comune. A fondarlo non fu un teologo né un filosofo accademico, ma un guaritore: Phineas Parkhurst Quimby, uomo convinto che molte malattie derivassero non dal corpo, ma dai pensieri. Per lui, cambiare le convinzioni sbagliate significava guarire: la mente poteva riscrivere la realtà.
Quimby non fu un caso isolato. Le sue idee si diffusero tra scrittori e pensatori come Ralph Waldo Emerson, il grande teorico del trascendentalismo americano, e ispirarono autori come James Allen, che nel suo celebre Come un uomo pensa (As a Man Thinketh) scriveva: “L’uomo è ciò che pensa: la sua vita è il riflesso dei suoi pensieri.” Il principio era semplice e dirompente allo stesso tempo: il pensiero crea il mondo.
Col tempo, il New Thought prese forma come un movimento spirituale e culturale con tanto di istituzioni e chiese dedicate. Non si può parlare, tuttavia, di una religione in senso stretto, ma piuttosto di una filosofia della mente che univa cristianesimo mistico, filosofia idealista e suggestioni orientali. Secondo il New Thought, ogni persona è una manifestazione del divino; Dio non è un’entità esterna, ma una forza che scorre dentro di noi e che può essere risvegliata attraverso la consapevolezza. La realtà non è qualcosa che subiamo, ma qualcosa che co-creiamo.
Questo modo di intendere la vita affascinò intere generazioni di lettori e di pensatori. Ernest Holmes, nel suo testo fondamentale The Science of Mind, sviluppò una vera e propria “scienza del pensiero”: una disciplina spirituale fondata sull’idea che la mente, se allenata, potesse plasmare l’esperienza umana. “La fede è un’energia che crea,” scriveva Holmes, “e ogni pensiero è un atto di creazione.”
Il “Nuovo Pensiero” odierno
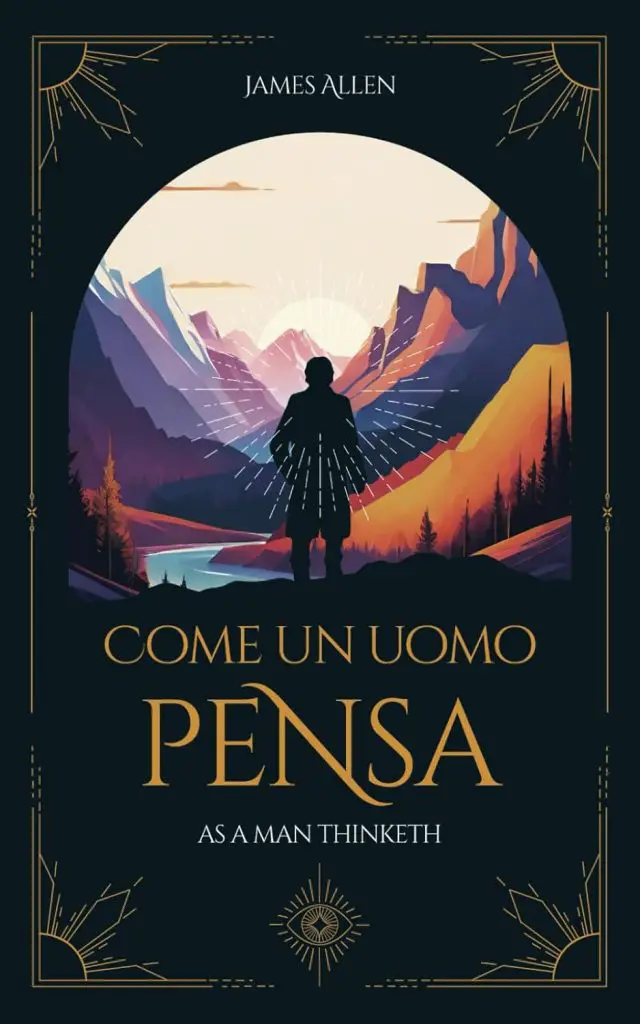
Ma dietro la sua patina di ottimismo, il New Thought nascondeva una profonda tensione filosofica. Se davvero tutto dipende dai pensieri, che ruolo resta alla realtà, alla sofferenza, al caso o, ancora, alla scienza? Non è forse rischioso ridurre il dolore umano a un semplice “errore di mentalità”? Queste domande accompagnano ancora oggi chi si avvicina al pensiero positivo e alle sue tante reincarnazioni moderne, dalla “Legge dell’Attrazione” fino ai manuali motivazionali più venduti.
Molti critici hanno accusato il New Thought e i suoi eredi di essere una forma di spiritualità superficiale, un “ottimismo obbligatorio” che finisce per colpevolizzare chi soffre. In un mondo come il nostro, in cui la produttività e l’efficienza sono diventate nuovi idoli, pensare positivo è spesso più un dovere che una libertà. Il rischio, come osservano diversi psicologi contemporanei, è trasformare la serenità in un’ulteriore performance.
Eppure, nonostante i suoi limiti, il New Thought continua a esercitare un fascino potente. Perché, al di là delle semplificazioni, nasconde una verità profonda: la mente influenza la realtà, se non altro nel modo in cui la percepiamo. Pensare in un certo modo non cambia il mondo in sé, ma cambia il modo in cui lo viviamo, e questo – spesso – basta per trasformare l’esperienza.
Basta guardarsi intorno per vedere quanto il suo spirito sopravviva oggi. La psicologia umanistica di Carl Rogers e Abraham Maslow, con la loro fiducia nel potenziale umano, deve molto al New Thought. Così come la diffusione della mindfulness, che pur provenendo dal buddhismo, ne condivide la centralità della consapevolezza e della visione interiore. E persino il mondo pop – con film, romanzi e corsi di self-help come The Secret di Rhonda Byrne – ne è un’eredità diretta, anche se spesso semplificata.

In fondo, l’idea che la realtà dipenda dal pensiero non è così diversa da ciò che molti filosofi idealisti europei sostenevano già secoli prima: Berkeley parlava di un mondo fatto di percezioni, Kant di un universo filtrato dalle categorie della mente. Il New Thought, nella sua veste americana, non fece altro che trasformare quella visione in un messaggio di speranza, accessibile a tutti: “Se puoi pensarlo, puoi farlo.”
Ma oggi, forse, è tempo di riscoprire il suo lato più profondo, e meno commerciale. Il vero potere del pensiero non sta nell’ottenere ciò che vogliamo, ma nel comprendere che siamo parte di un tutto più grande, e che ogni pensiero è un atto creativo che lascia un’impronta nel mondo. Non per forza magica, ma umana.
Il New Thought, con la sua miscela di misticismo e pragmatismo, ci invita a una forma di spiritualità gentile: quella che non impone di sorridere sempre, ma che ci spinge a guardare con fiducia e consapevolezza anche i lati bui della vita. Forse, come scriveva James Allen, “l’anima attrae ciò che segretamente ama”, e in questo, tra un pensiero e un respiro, si nasconde la vera magia.